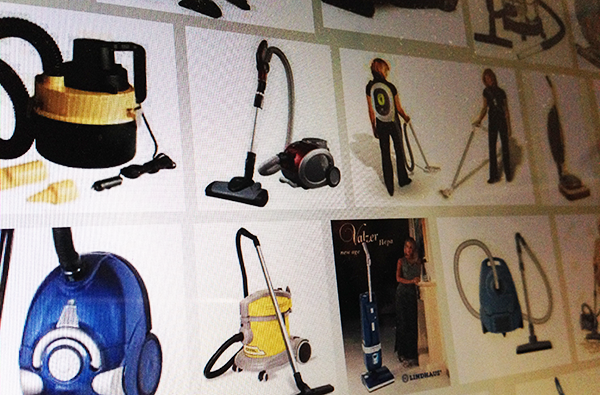
Negli ultimi 15 anni il giornalismo si è lasciato sfuggire ben più di un’occasione per garantirsi una sostenibilità economica. A coglierle, man mano che miliardi di persone salivano a bordo di questo gigantesco carosello che è il web, sono state soprattutto le compagnie che sulla rete ci sono nate.
C’era l’opportunità di creare spazi aperti di condivisione, di discussione e di approfondimento su ciò che accade nel mondo, spazi che avrebbero fruttato miliardi in ricavi pubblicitari. Aa occupare quelle praterie ci hanno pensato Facebook, Twitter, Youtube, Reddit e Tumblr, che oggi controllano i flussi di traffico ai siti dei giornali.
C’erano gli annunci, che nel 2000 per i giornali americani valevano 20 miliardi di dollari l’anno e che oggi ne valgono meno di 5. La gran parte del denaro se n’è andato nei fatturati di Craigslist, eBay e dei tanti siti specializzati, dalle auto al mercato del lavoro.
Di questi tempi, c’è un altro treno in partenza che potrebbe rivelarsi foriero di guadagni. La sfida è alla portata delle redazioni di giornali e riviste, di carta come online e siede a metà strada tra il gusto delle persone e l’e-commerce.
Le persone non scelgono dove vogliono andare in vacanza su Booking.com. Quando arriviamo su un sito per un acquisto, di solito già sappiamo cosa vogliamo. Le nostre scelte sono figlie di processi lunghi, complessi e personali che finora, online, sono stati misurati in maniera molto approssimativa.
Ma che c’entra tutto ciò con il futuro del giornalismo?
Chris Dixon, partner di AZ16, uno dei più lungimiranti fondi di venture capital americani, lo spiega meglio di quanto possa fare io:
Quasi nessuno decide cosa comprare sulla base di una ricerca su Google o di un link affiliato. Decidono in base a siti di contenuti – Gizmodo (un sito di tecnologia, NDR), New York Times, Twitter, etc. Questi siti aiutano a generare desiderio, che è la parte più importante della creazione dell’intenzione d'acquisto, che a sua volta è direttamente correlata ad alti ricavi pubblicitari.
Ma i siti di contenuti non hanno alcun modo di misurare il loro ruolo nella generazione dell’intenzione d'aciquisto. Spesso, la creazione di desiderio non è attribuibile ad un unico clic che può essere misurato.
L’analisi è del 2009 e da allora alcune cose sono cambiate. Startup il cui unico fine è aiutare le persone a scoprire prodotti interessanti hanno attirato decine di milioni di utenti e con essi, centinaia di milioni di dollari d'investimenti. In soli cinque anni di attività, Pinterest ha raccolto fondi per 762 milioni di dollari, mentre un’azienda simile ma più di nicchia, Fancy, ne ha ricevuti 104.
Dall’altro lato della staccionata, i dipartimenti di vendita e marketing delle grandi aziende pagano decine di miliardi di dollari l’anno ad agenzie di intermediari (i cosiddetti data broker) per braccare gli utenti online e tracciare profili delle loro possibili preferenze in base alle loro ricerche o ai siti che visitano.
È una pratica eticamente molto discutibile e di dubbia efficacia – lo sa chi (come me) non possiede un auto ma continua a vedersi proposte pubblicità di assicurazioni – ma la quantità di denaro spesa per cercare di azzeccare una nostra potenziale preferenza è un segnale di quanto sia alta la posta in gioco.
«Nessuna quantità di marketing analytics può essere preferibile al sapere esattamente cosa l’utente vuole», dice Doc Searls, storico blogger, ricercatore ad Harvard e autore dei libri "The Cluetrain Manifesto" e "The Intention Economy".
E in effetti, nonostante i miliardi di dollari investiti dalla Silicon Valley, nessuno sembra essere riuscito a “chiudere il cerchio” delle vendite online, trovando una continuità tra la spesa pubblicitaria delle aziende e le abitudini d’acquisto delle persone.
Forse, come suggerisce Dixon, la chiave potrebbe risiedere nei produttori di contenuti professionisti, che da decenni aiutano le persone a scoprire cose nuove, curiose e interessanti. Basti pensare alle recensioni delle pagine di cultura e del tempo libero, o agli inserti settimanali di auto, case, tecnologia, moda e viaggi.
Le sezioni del weekend dei principali quotidiani sono inviti a leggere libri, vedere film, acquistare abiti e gadget e visitare luoghi. Suggerimenti che una buona parte della popolazione – quella con più reddito disponibile – raccoglie con gusto. Non è un caso che uno degli inserti più celebri del Financial Times, di recente entrato in partnership col Sole 24 Ore, si chiami “How to Spend It.”
Non c’è però il rischio che ancora una volta, le startup e le aziende di tecnologia imparino a diventare produttori di contenuti di alta qualità prima che i giornali o le riviste imparino a monetizzare queste intenzioni d’acquisto?
La risposta (sì) sta nella quantità di giornalisti, videomaker e produttori di contenuti professionisti che vengono assunti ogni anno dalle aziende web.
I giornali e le riviste oggi, tuttavia, hanno tre distinti vantaggi.
Per cominciare, una bella recensione su un grande quotidiano ha un grandissimo valore per convincere il pubblico della qualità di un prodotto o di un’azienda. Lo sanno bene gli addetti stampa e le aziende di public relations, che spesso lavorano settimane per ottenere copertura mediatica dei loro clienti su una grande testata.
Il secondo vantaggio risiede nel fatto che le aziende di tecnologia non amano le procedure che non possono essere affidate a un computer. Quando possono – e spesso anche quando non c’è bisogno – cercano di automatizzare. Gli algoritmi di Facebook per esempio, cercano di azzeccare automaticamente quali articoli potrebbero interessarci, mentre quelli di Foursquare quale pizzeria provare stasera, ma spesso finiscono per offrirci suggerimenti scontati, basati solo sulla popolarità di alcuni elementi.
I giornalisti di settore invece, sono da sempre abituati a fare da filtro, aiutando le persone a scovare le piccole perle, i nuovi trend, i prodotti e le possibilità inesplorate. I più bravi tra loro hanno il ‘polso’ del loro settore e un intuito che funziona meglio degli algoritmi più sofisticati.
Il terzo e ultimo vantaggio è la clamorosa (e ancora in corso) debacle sull’uso dei dati personali da parte dell’industria tech. Le grandi compagnie del web non sono affatto estranee alle pratiche di profilazione descritte sopra e la recente presa di distanza da parte dell’amministratore delegato di Apple Tim Cook la dice lunga sul potenziale effetto tossico di questi comportamenti:
Qualche anno fa, gli utenti di servizi web hanno iniziato a rendersi conto che quando un servizio è gratuito, vuol dire che non sei il cliente. Sei il prodotto.
Ad Apple crediamo che un’eccellente esperienza per i clienti non debba andare a scapito della loro privacy. Il nostro modello di business è molto chiaro: vendiamo prodotti eccellenti. Non creiamo un profilo da vendere a pubblicitari in base ai contenuti della tua casella email o delle tue abitudini di navigazione
*
Anche io, nel mio piccolo, con un passato da giornalista al Wall Street Journal ed Agence France-Presse e un presente nel campo della tecnologia, sto provando a cavalcare questa opportunità. Due settimane fa ho lanciato un'app iPhone, Fleisure, che serve ad appuntarsi e a ricordare le cose che voglio fare nel tempo libero: un libro da leggere, un film da vedere, o un ristorante da provare.
L’idea è quella di aiutare le persone a catturare tutte le piccole intuizioni quotidiane rispetto al proprio gusto, intuizioni che anche i giornali, le riviste e le pubblicazioni online di alta qualità dovrebbero iniziare a valorizzare. Perché è in quel momento che una persona inizia a diventare un potenziale cliente.
Lavorare in questa direzione richiede grandi sforzi tecnologici da parte degli editori. Non coinvolge granché molti giornalisti – per esempio chi si occupa di politica, di nera o di cronaca giudiziaria – e richiede da parte degli editori un sistema di pesi e contrappesi che possa proteggere l’integrità della professione da eventuali tentazioni.
Dice Dixon:
Anche se ci fosse un modo per misurare la creazione di intenzione, al giorno d’oggi farlo sarebbe visto (da parte dei siti di contenuti NDR) come una violazione della separazione tra pubblicità e contenuti editoriali. E così, ai siti di contenuti rimane solo l'opzione di mostrare banner e contrattare sui CPM (i prezzi a cui vengono venduti i banner NDR) senza che venga in alcun modo misurato il loro contributo alla creazione di intenzione di acquisto.
È una sfida potenzialmente molto lucrativa, che molti giornali e riviste sono ben attrezzati per affrontare. E di cui hanno disperatamente bisogno.


