Questa settimana in RoundUp: la nuova iniziativa del Corriere.it, che inviterà i propri lettori a prendere parte al processo di fact checking grazie a una piattaforma della Fondazione Ahref; una testimonianza sul funzionamento del sistema di verifica dei dati e delle fonti al New Yorker; il difficile rapporto tra giornalismo e verità nell'epoca delle opinioni diffuse; il dibattito del forum organizzato dal Poynter Institute sulla rilevanza giornalistica e il senso della professione per le nuove comunità; i nuovi dati sulla raccolta pubblicitaria del New York Times, in forte contrazione malgrado la crescita di diffusione e abbonamenti al paywall.
sul Corriere
Da martedì 23 ottobre i lettori del sito del Corriere della Sera possono collaborare con i giornalisti della testata nella ricerca di fonti e notizie partecipando ad un processo di fact checking che li porterà a «prendersi cura insieme del giornale»: la testata milanese ha infatti deciso di adottare la piattaforma FactChecking.it della Fondazione Ahref per consentire ai cittadini di lavorare insieme ai redattori al processo di formazione e verifica delle notizie attraverso un sistema di segnalazione di fonti, basato sulla ‘reputazione’ dell’utente premiato in ragione della validità dei contenuti proposti. Basterà registrarsi a Civic Link, il network di media civici creato dalla Fondazione, e accettare i «principi chiave» (accuratezza, completezza, indipendenza e legalità) che sono da sempre alla base del metodo Ahref - e con tanto di certificazione di qualità.
Da questa settimana, quindi, i lettori di Corriere.it troveranno un tasto ‘fact checking’ di fianco al titolo della notizia per cominciare a lavorare su una dichiarazione o su un dato contenuto nell’articolo, proponendo così la ricerca agli altri utenti registrati e invitandoli a contribuire al lavoro di certificazione. Un modello collaborativo che trova i propri precedenti in esperienze come Wikipedia e che è uno dei portati storici del nuovo scenario di internet, spiega Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera: «Chiediamo quotidianamente trasparenza alla politica, all'economia, a chiunque. Il giornalismo non può esserne estraneo, deve essere aiutato nel suo farsi». Ma, assicura, «non è sottoporsi al giudizio dei lettori: è iniziare un percorso assieme».
Di apertura interessante parla Pier Luca Santoro sul suo blog, che però non fa a meno di notare quanto la presenza sul portale, al momento, non sia delle più partecipate: pochi gli interventi finora raccolti, risultati che lo portano a considerare quanto probabilmente sia «necessario lavorare sulla motivazione delle persone, incentivandole, spingendole a dare il proprio contributo». Più critico invece Lucio Bragagnolo su Apogeonline che ricorda come la pratica della verifica dei fatti, nelle redazioni, sia responsabilità giornalistica che altrove esiste da decenni e sopravvive, malgrado tutto, ancora oggi: «Agli inizi del Duemila, Der Spiegel aveva ottanta persone adibite al fact checking. Il New Yorker sedici, il New York Times qualcuna meno. Ma non è questo. È che nella pagina di Corriere.it manca la parola responsabilità».
del fact checking del New Yorker

E proprio New Yorker e fact checking sono protagonisti in settimana di un post della Columbia Journalism Review, nel quale è stato pubblicato il capitolo Fact-checkin at The New Yorker, tratto da una conferenza del 2002 dal Fact-Checking Director della testata Peter Canby, e estratto del libro The Art of Making Magazines: On Being an Editor and Other Views from the Industry di Victor S. Navasky e Evan Cornog. Nel testo gli autori raccontano dell’evoluzione del ruolo del fact checker all’interno della redazione: presenza fissa e irrinunciabile sin da subito, poi soggetta a revisioni e tagli dovuti anche all’avvicendarsi delle linee editoriali e al sopraggiungere delle crisi economiche.
Stando al libro, prima dell'arrivo di Tina Brown alla direzione (attuale Editor in Chief di Newsweek di cui abbiamo parlato la settimana scorsa) e quindi sotto William Shawn, dal '52 all'87, la redazione era arrivata a comprendere anche otto addetti al fact checking, un lavoro fondamentale per il prodotto finale nel quale la cura per il dettaglio e la precisione non erano mai lasciate al caso: agli autori, raccontano, veniva permesso di lavorare sul proprio articolo per tutto il tempo ritenuto necessario - cosa che spesso significava ritardi di anni e rallentamento nella produzione e nella chiusura dei numeri. Il pezzo, una volta completato, veniva quindi accettato, editato, rivisto, e quindi passato al vaglio del fact checker, un processo lungo e meticoloso che richiedeva generalmente settimane, se non mesi («Durante gli anni di Shawn, le recensioni di libri duravano mesi – quando non anni - fuori sincrono con le uscite editoriali», mentre sotto Tina Brown «abbiamo cominciato a far pezzi da 8, 10, 12 mila parole da chiudere entro il mercoledì successivo»).
Nel testo, attraverso diversi esempi, viene raccontato l’intero processo di cura dei testi e dei fatti, un sistema che «sembra funzionare» fondato su applicazione e pazienza, che cerca di produrre «as right as we can», al meglio, attraverso il controllo e la verifica la produzione altrui. Operazione mai facile: «lavorare sulle note di qualcun'altro non è una scienza. Pretende giudizio, discrezione, forte sensibilità. Cose che si ottengono solo con l'esercizio, su cosa è accettabile e cosa no». E leggere di modalità e tempi di lavoro di questo tipo, pensando alle consuetudini del giornalismo online, del blogging e del social networking, contribuiscono di certo a rafforzare la nozione di «arte del fare magazine» contenuta nel titolo stesso del libro.
La sfida della verità nella produzione diffusa di opinioni
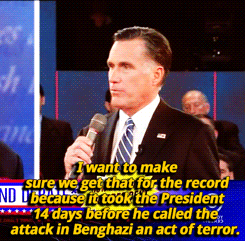
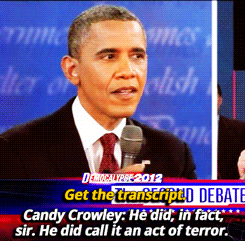
L'esercizio del fact checking, sebbene spesso deputato a gruppi redazionali dedicati che operano da veri e propri professionisti della verifica, si è ovviamente evoluto con l'ingresso nel settore dei media online e di strumenti accessibili a tutti che fanno di ogni lettore un potenziale fact checker. Appaiono lontani i tempi dell'assunzione monodirezionale delle notizie da radio e televisione, che non lasciava al lettore o allo spettatore che la possibilità di apprendere una sola versione degli eventi – che fosse veritiera o meno. Tuttavia oggi, com’è noto, attraverso quella che Om Malik ha definito «democratition of distribution» è possibile rintracciare migliaia di ‘verità’ diverse in rete per qualsiasi tipo di notizia. Ma come determinarne la veridicità effettiva? Quale versione scegliere, e su quali basi? È uno dei temi del forum organizzato questa settimana dal Poynter Institute e da CraigConnects - un progetto del fondatore di Craiglist Newmark – sull’etica giornalistica nell’età digitale (qui trovate lo Storify).
Secondo lo scrittore e studioso Clay Shirky, tra i relatori, il passaggio dalla consultazione quasi oracolare delle notizie dai vecchi media all'introduzione dei nuovi mezzi ha fatto sì che il raggiungimento del punto di condivisione sulla realtà dei fatti, oggi, sia quasi un elemento irraggiungibile, un rapporto – quello tra giornalismo e verità – mai stato più complicato, in ragione dal fatto che chiunque può essere in grado di far sentire la propria voce su qualsiasi argomento, come in una gigantesca chat room nella quale è potenzialmente invitato chiunque abbia a portata di mano una tastiera.
Tutto questo porterebbe quindi a un processo di caotico impoverimento della professione, uno strumento ormai obsoleto da rivedere completamente persino nei valori fondanti, come quello dell’’oggettività’ («una nozione che i media hanno tirato fuori negli anni ’50-‘60 per attrarre il pubblico di massa e di conseguenza gli inserzionisti pubblicitari)»: non è più necessario perseguire questo sorta di mito fondativo, «dovremmo smettere di usare questa parola», taglia corto Shirky. Che conclude: «Le strategie sviluppate per raccontare il vero nel ventesimo secolo oggi, semplicemente, non funzionano più». Eppure da rivalutare, quanto meno, sarebbe la figura del gatekeeper, redazioni pronte a vagliare e confrontare i contributi esterni, in un pieno e corale coinvolgimento fra i giornalisti e «le persone un tempo definite lettori» - secondo una descrizione di Jay Rosen.
Un processo sicuramente più caotico, un modo più faticoso di giungere all'onestà dei fatti, ma che secondo Mathew Ingram, in conclusione, potrebbe essere il migliore per avvicinarsi il più possibile all’adesione al vero, molto più che nel processo di produzione ‘verticale’.
L’etica giornalistica nell’era digitale

Di certo, continua Shirky, «l’idea che qualcosa chiamata stampa abbia ancora una reputazione fra coloro che generalmente chiamiamo pubblico è qualcosa che si sta via via perdendo», e con esso «il modello centralizzato di informazione nazionale di tipo mainstream», una sorta di processo di inesorabile decentramento: uno dei temi ricorrenti del forum del Poynter Institute è proprio il cercare di trovare il modo di continuare a garantire rilevanza ai giornalisti e all’informazione negli scenari futuri. Le notizie, così come riproposte nel ciclo degli aggiornamenti, rischiano di diventare sempre più invisibili agli occhi del lettore – e i giornalisti, come emerso dal dibattito, dovrebbero iniziare a convivere con l’idea che il sistema di pubblicazione degli articoli e la relativa attesa per il pubblico, aspettando che si attivi autonomamente e legga, è un sistema da ripensare completamente specie se si pensa al fatto, come ricordato dal capo del Data Science Team di SocialFlow Gilad Lotan, che «tutto ciò che viene pubblicato online è accessibile a tutti, ma non ugualmente rintracciabile».
È necessario trovare nuovi metodi di coinvolgimento, in modo da stimolare la readership e dar voce alla propria comunità - e il fact checking in qualche modo si inscrive in questa logica. «Il nostro obiettivo – spiega Craig Silverman del blog Regret the Error su Poynter - non è solo informare il pubblico, ma connetterci con loro attraverso storie, condividere le esperienze e gli avvenimenti principali nel nostro mondo. Per farlo, dobbiamo agire con umanità, coi valori e l’emozione che ispirano le connessioni umane». Proprio per questo, al di là del rapporto fra etica e algoritmi - tra i temi del simposio del 23 ottobre - secondo Silverman sarebbe necessario ricordare sempre che le radici etiche del giornalismo affondano nell’umanità, più che nella tecnologia – tra i concetti più apprezzati e condivisi dell’evento. E che «our principles must be technology agnostic».
Il ruolo del giornalista, a questo punto, sarebbe quello di un professionista capace di creare standard elevati di giornalismo per la propria comunità – suggerisce la giornalista del Seattle Times Monica Guzman. Anche abbracciando modelli editoriali più ragionati e ‘lenti’, dando loro il senso del racconto come servizio prestato alla comunità, indispensabile nel modo unico e reperibile di riportare storie: «per me, il futuro del buon giornalismo dipende più dalla visibilità, o dalla ‘trov-abilità’, dai contenuti intelligenti», spiega Kira Goldenberg sul sito della Columbia Journalism Review a margine della discussione. «I giornalisti devono riconoscere che stanno usando solo una piccola parte dei social network», pena – appunto – la perdita di rilevanza.
Il calo delle entrate pubblicitarie del New York Times

Intanto il mercato continua a dare segnali negativi anche per i grossi gruppi che sembravano aver trovato quanto meno una strada percorribile per il futuro tutto digitale del’editoria: le entrate totali provenienti dalla pubblicità, per il gruppo del New York Times, sono scese dell'8,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - trend negativo sia per il cartaceo che per il digitale, in controtendenza rispetto alle entrate derivanti dalle vendite in crescita del 9,3%.
Secondo la Chief Advertising Officer Denise Warren il crollo rifletterebbe le difficoltà derivanti dal mix prodotto dalla ben nota crisi ciclica e dagli altrettanto famigerati cambiamenti epocali in atto nel settore, il proverbiale 'cocktail letale' che avrebbe portato anche le entrate digitali a scendere nel terzo quarto del 2012 del 2,2%, il 2% totale negli ultimi nove mesi. Buone notizie, invece, dal settore paywall: più 11% alla fine della prima metà del 2012.
Dati che non bastano a smentire il pessimismo del Digital Transformation Editor di Digital First Media Steve Buttry, che sul proprio blog invita gli ‘estimatori a prescindere’ del modello del Times a tener conto delle perdite economiche della testata, delle imbarazzanti difficoltà tecniche che spesso rallentano la sottoscrizione all’abbonamento digitale, e anche – infine – della mancanza di idee del gruppo quanto a modelli alternativi: «potrei sbagliarmi sul fatto che i paywall non siano la strategia giusta – ammette Buttry - e che il Times stia seguendo una strategia vecchia. E ammetto di non avere tutte le risposte su quale sia la strada giusta per il giornalismo digitale. Ma di certo so che non lo sanno neanche loro».



