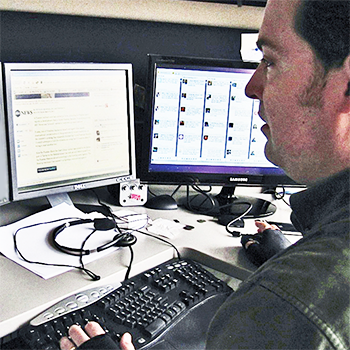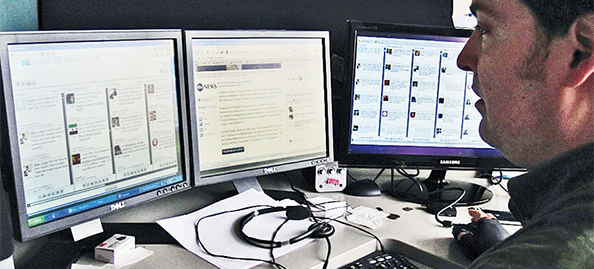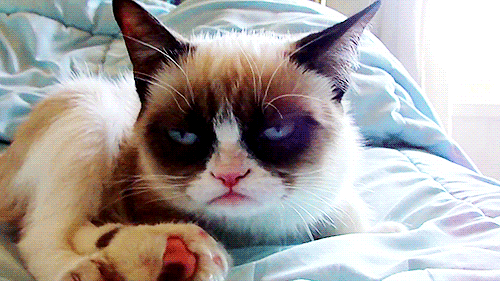Questa settimana in RoundUp: Twitter presenta Vine, una nuova applicazione video che porta pro e contro nel mestiere giornalistico; come verificare le informazioni guadagnate su Twitter, trattandolo come una fonte 'classica', e l'esempio di Andy Carvin intervistato da The Verge; Kanalley dall'Huffington Post US si chiede se i giornalisti non scherzino troppo sui social network, citando una ricerca; e infine la sfida del conversational journalism e i commenti anonimi su TechCrunch.
Vine e i video su Twitter
Questa settimana il CEO di Twitter Dick Costolo ha pubblicato sul proprio social network un video a tema culinario di pochi secondi: si è trattato del lancio ufficiale di Vine, un'applicazione stand-alone (quindi non integrata, ma da scaricare a parte) pensata da una start up acquistata dalla corporation di San Francisco nell'autunno scorso, e che secondo molti si appresta a diventare la risposta effettiva all'acquisto di Instagram da parte di Facebook. L'applicazione, disponibile per ora solo per iPhone, iPod e iPad, permette registrare video di sei secondi («che equivalgono evidentemente a 140 caratteri», fanno notare) alla semplice pressione dello schermo, e quindi di poterli condividere su vari social network. Secondo John Battelle, si tratterebbe di una sorta di passaggio evolutivo di Twitter da semplice social a vera e propria media company, come dimostrato peraltro dall'implementazione di nuovi servizi come il rinnovato sistema di embedding dei tweet. Una nuova 'era' che avrà però bisogno di sempre maggiore cura delle informazioni e che, secondo Ingram su Paid Content, rischia di allontanare la società da sforzo e ragioni del successo iniziale: la cruda essenzialità, adattata col tempo al gusto e ai suggerimenti dell'utenza.
I video - per i quali l'avanzamento della registrazione corrisponde alla pressione sullo schermo, permettendo così agli user di creare una sorta di montaggio - vengono riprodotti all'infinito, come a voler emulare l'impatto grafico, e quindi giornalistico, delle già note GIF animate, rendendo la creazione più 'giocosa', artistica, ma anche - all'occorrenza - utile. Jeff Sonderman, su Poynter, ha già indicato quali potrebbero essere i pro e i contro di questa nuovo strumento video. Partendo dagli effetti potenziali sul racconto delle storie e sulla pubblicazione in diretta delle testimonianze: una cosa, spiega, è confrontare i diversi punti di vista fotografici su un dato evento, ben altra è consultare le diverse prospettive di quel dato evento con un mezzo più realistico come quello dei video - con ‘vista’ sui tutti i dilemmi etici del caso, sulla crudezza di alcuni contenuti, come in parte dimostrato in passato con mezzi già attualmente disponibili. Per farla breve, danni e benefici - in proporzione - s'apprestano a essere maggiori, e bisognerà imparare a farci i conti.
Come usare Twitter da giornalisti
«I giornalisti dovrebbero trattare le informazioni ottenute sui social media nello stesso modo in cui trattano quelle ottenute con qualsiasi altro mezzo», esordisce Steve Buttry in un post di lunedì scorso su come gli addetti ai lavori debbano controllare e verificare fonti e informazioni sul social network. I consigli miscelano semplice buon senso e applicazione della pratica giornalistica della verifica: Buttry raccomanda di 'sporcarsi le mani' usando il più possibile Twitter così da identificare, riconoscere e instaurare rapporti con fonti che col tempo si possono ritenere affidabili, esaminare attentamente i profili di chi fornisce informazioni - e far ‘suonare l'allarme’ se si tratta di account freschi d'iscrizione o con pochi tweet -, controllare la rete di conversazioni del 'sospetto’ e non dimenticare mai il contesto, facendo sempre attenzione all'ora, alla data del tweet e alla sua geolocalizzazione - laddove disponibile. Infine, ricordare sempre di cercare - tramite la ricerca avanzata - altri profili che hanno raccontato o che sono testimoni di quello stesso evento, così da confermare la veridicità, o quanto meno la coerenza, dei contenuti multimediali proposti da questo tipo di fonti.
Pratiche non certo ignote a uno dei protagonisti dell'universo giornalistico in rete: Andy Carvin, intervistato questa settimana da Jesse Hicks, ha raccontato a The Verge di come abbia sviluppato le sue tecniche di verifica e condivisione istantanea delle informazioni su Twitter, un lavoro che ha preso piede con le dimostrazioni di massa durante la cosiddetta Primavera Araba e che è stato raccontato nel suo ultimo libro «Distant Witness: Social Media, the Arab Spring and a Journalism Revolution» e in un keynote speech nell'edizione 2012 del Festival Internazionale del Giornalismo (qui il video). Considerato «l'uomo che twitta le rivoluzioni» (il Guardian), un «one-man Twitter news bureau» (Washington Post), Carvin preferisce esser definito una sorta di DJ, o meglio ancora un news anchor, che lavora su «notizie in tempo reale e cerca di condividere le più interessanti coi propri follower». Un’intervista che non dimentica di citare critiche (come quella mossa da Michael Wolff per il suo atteggiamento sulla sparatoria alla Sandy Hook School) e che, alla fine, spiega quale possa essere il senso del ‘saper twittare’ per semplici utenti senza velleità giornalistiche.
Ma i giornalisti scherzano troppo su Twitter?
Se l'è chiesto mercoledì scorso il Senior Editor di Huffington Post Craig Kanalley. «Non voglio passare come uno senza senso dello humor: mi piace ridere, e penso che ridere sia una parte importante della vita» precisa Kannalley. «Seguo giornalisti che credo facciano un buon lavoro combinando umorismo e reporting»: a chi non piace ridere?, aggiunge, prima di passare a una accusa che - ammette - conservava da tempo ma che non ha mai reso pubblica: se è vero che il mestiere del giornalista è qualcosa di serio - ed è uno dei motivi per il quale l'autore stesso dice di aver intrapreso questa strada - perché allora Twitter è così pieno di battute di giornalisti - talvolta anche su eventi per niente allegri?
Di certo, Twitter può essere un grande strumento di engagement, buono per fare comunità - e il recente caso di Sullivan e i contributi dei lettori per il suo The Dish ne è un prova lampante - e comunque un mezzo sul quale ci si iscrive da utenti comuni, da «esseri umani», sebbene con addosso il fardello - obietterebbe qualcuno - del valore 'pubblico' della carica che si ricopre, e il fatto che ogni giornalista, in qualche modo, è portavoce della propria testata.
Ann Friedman, su #Realtalk della Columbia Journalism Review, nell'ottobre scorso parlava proprio della necessità di 'umanizzare' il proprio profilo giornalistico su Twitter, «Il posto perfetto per commenti irriverenti»: «Make more jokes!», era l'invito. Che sembra quasi esser stato accolto: secondo uno studio Avery Holton e Seth Lewis delle università di Texas e Minnesota, fra i tweet dei giornalisti più seguiti, quasi un quarto (il 22,5%) avrebbe avuto una valenza umorisitica. Forse troppi, secondo il Senior Editor dell'HuffPost, che ricorda quanto le parole, una volta rese pubbliche, abbiano un peso possano portare a delle conseguenze.
Il giornalismo conversazionale e la comunità
Il rischio ulteriore, infatti, sarebbe quello di appiattire la personalità giornalistica all'ambiente nel quale si è deciso di 'conversare' con gli altri utenti, coi propri lettori, fino a rendere indistinguibile la differenza fra professionisti della comunicazione e semplici cittadini. È in qualche modo la cifra dell'editoria online più recente, la sfida del conversational journalism citata giovedì da Jason Kottke sul proprio blog: «I giornali più in vista in questi tempi - esordisce, citando TMZ, BuzzFeed, Huffington - prendono principalmente la forma di conversazioni basate su opinioni: professionisti dei media che discutono di eventi così come potrebbero farlo i tuoi amici seduti attorno a una tavola chiassosa». Con l'effetto che diventa sempre più difficile capire, nel frastuono, chi sia il professionista e chi l'amatore in realtà inesperto. Un chiacchiericcio dal quale il professionismo in rete potrebbe non essere in grado di trarre giovamento, che intende assecondare i gusti dei lettori, coi loro linguaggi più colloquiali per dibattiti dalle tematiche facilmente accessibili (e i casi citati sono quelli di Manti Te'o e del Beyonce lip-sync scandal). «Speculation is fun and people want their news to be fun».
D'altra parte quello della discussione è un ruolo chiave nell'informazione online, e negli ultimi anni non sono state poche le testate che hanno deciso di scegliere policy e metodologie di inserimento diverse per i commenti, alla ricerca di un sistema affidabile e comunque aperto. Nel 2011 TechCrunch ha deciso di sostituire il classico form di commento con quello di Facebook, che necessita dell'autenticazione dell'autore, così da disincentivare le invasioni dei troll delle settimane precedenti. Tuttavia pare che il sistema abbia funzionato ‘troppo’, e che la rinuncia all'anonimato abbia condotto la maggior parte dei commentatori a non prendere più parte alla discussione in fondo ai post. Martedì TechCrunch ha deciso di tornare a dare la possibilità dell'anonimato nei commenti grazie alla tool Livefyre - company che ha come motto «We make your site social». «Commenters, We Want you back» è il titolo del post che dà conto della novità. Nell'immagine, su un foglio, una scritta con grafia a mano: «I miss you, asshole».