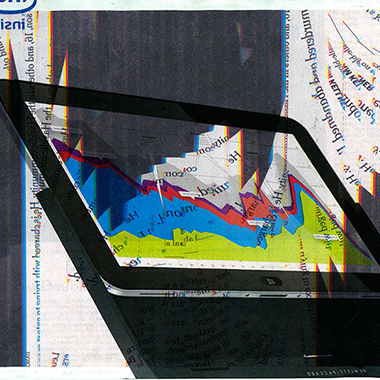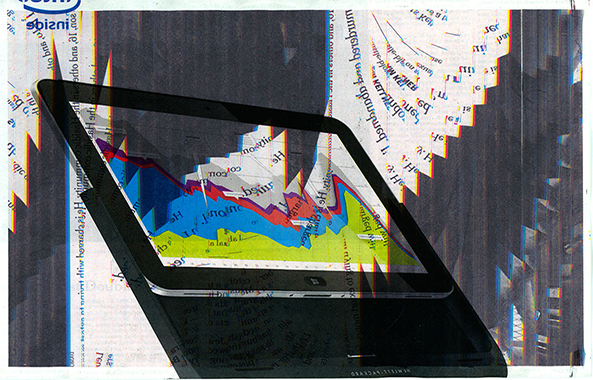
Accadono nel mondo dell’editoria e dei giornali cose che appaiono profondamente diverse. Miliardari che comprano giornali cartacei, grandi aziende che se ne liberano alla stregua di rami secchi. In realtà, nel processo di trasformazione dell’editoria, da cartacea a digitale, la necessità di meglio individuare il proprio pubblico (mercato) è alla base di una vera e propria ristrutturazione identitaria delle aziende.
———
In quindici mesi, a cavallo del 2012, il miliardario americano Warren Buffett ha acquistato 30 quotidiani locali/regionali negli Stati Uniti, affermando nella annuale lettera agli azionisti lo scorso primo marzo:
I giornali continueranno a regnare sovrani, comunque, nell’informazione locale. Se vuoi sapere cosa sta accadendo nella tua città – che la notizia riguardi il sindaco o le tasse o la squadra di football del liceo – non puoi fare altro che leggerle sul giornale locale. Gli occhi del lettore possono appannarsi dopo aver letto un paio di paragrafi sulle tariffe canadesi o sugli sviluppi politici in Pakistan. Una storia che riguardi direttamente lui o il suo quartiere sarà letta fino in fondo. Ovunque vi sia un forte senso di comunità, un giornale che serve le speciali necessità informative di quella comunità, resterà indispensabile per la gran parte dei suoi membri.
Affermazione che, sulla sottile ed impalpabile linea della logica, sembrerebbe non fare una piega. Ma con la logica non si compra pane come, a proposito della “spesa” di Buffett, ha affermato, a suo tempo, Shirky:
[…] lui dà molta importanza alla “goccia” dei lettori, ma la vendita delle copie non è mai stata fortemente correlata con le entrate negli ultimi vent’anni. [… ] Si allude al rapporto tra lettori e giornali una mezza dozzina di volte in una nota di un migliaio di parole; in quello stesso spazio, non ha mai usato una volta le parole 'pubblicità' o 'inserzionisti’. Leggendo la lettera, non diresti mai che i giornali ricavano la maggior parte del loro denaro dalle aziende, non dai lettori, e lo hanno fatto per la gran parte di due secoli. È la concorrenza distruttiva per i soldi della pubblicità, non un minore coinvolgimento del lettore, che ha mandato in tilt l’industria editoriale.
D’altra parte le parole di Shirky del 2012 sembrano, almeno apparentemente, contraddette dal risultato, proprio dello scorso anno, del New York Times: per la prima volta nella sua storia recente, le entrate delle vendite (grazie anche ad un forte incremento delle sottoscrizioni digitali) hanno superato le entrate della pubblicità: una pietra miliare, come scriveva Ken Doctor. Comunque una svolta storica.
Insomma difficile, se non si entra nel merito, come tenteremo di fare, cavare un ragno dal buco. Anche perché, “last but not least”, altri eventi hanno contribuito ad aumentare significativamente il numero delle tessere del puzzle.
Lo scorso anno Ruperth Murdoch ha deciso di separare le aziende editoriali (News Corp) che incorporavano testate come il Wall Street Journal ed il Sun of London, dalla produzione televisiva ed entertainment (Twenty-First Century Fox): al termine del processo, il mese scorso, Twenty-First aveva quasi raddoppiato il valore delle azioni, News Corp perdeva oltre il 16%. Nel frattempo, a marzo, Time Warner ha deciso di vendere l’intero settore editoriale (Time Inc magazine group), operazione ancora in corso, mentre Tribune Co., nell’annunciare l’acquisto di alcune tv locali ha anche informato di voler separare le attività editoriali (includono Chicago Tribune, Los Angeles Times e le altre testate del gruppo) da quelle televisive, dividendosi in due società.
Questa politica di separazione delle attività editoriali da quelle televisive e di intrattenimento, secondo Alan Mutter, è essenzialmente dovuta alla necessità, per le grandi aziende mediatiche, di separare i rami secchi dell’editoria dalle attività ancora fiorenti del broadcasting, incentivando gli investitori a rafforzare le proprie quote di investimento da una parte, ma anche a trovare quelli che (se ancora ve ne fossero) potrebbero essere intenzionati a spendere per i giornali.
Ma allora dov’è la ragione? Buffett che crede nei lettori per il suo sorgente impero iperlocale o Shirky che ritiene che senza pubblicità non si può aprire bottega? È il risultato del New York Times sulle vendite esemplare o rappresenta un faro nella notte? Sono nel giusto le grandi aziende mediatiche nel voler disfarsi dei rami secchi dei giornali?
Probabilmente ogni tessera di questo puzzle non è in realtà corrispondente a nessuna altra di quelle elencate: non sono incastrabili.
Questo perché l’ecosistema dell’informazione oggi è così articolato e complesso che non può più essere individuato alcun principio universale che ne governi il funzionamento. Non esiste principio di scarsità o teoria funzionalista che possa calzare le diverse, innumerevoli realtà del mondo dell’informazione che, quotidianamente si generano, si creano dal nulla, individuando forme e percorsi sinora mai pensati.
È vero, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sostiene Buffett, che l’informazione locale ha una sua dignità ed un potenziale di interesse ancora enormi. Ma solo se, a quelle testate cartacee la sua azienda saprà far corrispondere un'evoluzione tecnologica e digitale tale da riuscire a trovare i propri lettori lì dove essi si sono trasferiti: nel mondo virtuale della rete. Come ha dichiarato Manuel Castells: “Quando la attuale generazione di sessantenni si esaurirà, non ci sarà nessun giornale stampato senza sovvenzioni. Ma l’informazione ed il giornalismo prospereranno nel mondo della comunicazione virtuale, che gli editori dovranno condividere con i blogger e gli altri abitanti della rete”.
Shirky , nella sua certezza sulla pubblicità come fonte primaria di ricavo, si riferiva evidentemente alla carta, non al digitale. Ed il New York Times di Mark Thompson ha dimostrato che anche un grande giornale, emblema della tradizione e del passato, può (e deve) rinnovarsi, innanzitutto partendo dalla individuazione del suo pubblico di riferimento: allora via al grande giornale globale, unica chance per chi vuole fruire dei vantaggi della lingua e del suo brand internazionale, pronto a spartirsi quel pubblico, con pochi altri competitors. Almeno per il momento.
E sempre nella logica della individuazione del pubblico di riferimento, della specializzazione e della verticalità, che possono essere inquadrate le strategie separatiste di Murdoch e degli altri big player dei media prima elencati.
E allora tornando su a rileggere queste poche righe, forse alcune similitudini, punti di passaggio comuni, possono essere individuati: il pubblico delle testate locali di Buffett è un pubblico specifico, con sue peculiari caratteristiche ed esigenze, diverso, ma altrettanto specifico e peculiare, da quello delle grandi testate come Guardian e NYT. Come quello dei grandi player dei media televisivi e cinematografici, che non possono continuare a confondere i loro spettatori con i lettori dei giornali che avevano acquistato nei momenti voraci dello “splendore” (in senso lato) dell’industria culturale.
D’altra parte una specializzazione ed una brandizzazione che si sono già verificate, a partire proprio dagli Stati Uniti, nel mondo della televisione, nel corso degli anni ’90, quando le tv generaliste, a fronte dell’avvento dei satelliti e delle tv via cavo, hanno dovuto lasciare lo spazio a migliaia di canali specializzati, ciascuno con un proprio pubblico specifico e ben individuato.
Individuare il proprio pubblico di riferimento presuppone anche, a monte, avere chiaro il tipo di prodotto che si vuole offrire, essere consapevoli di avere le capacità e le risorse per realizzarlo, elaborare una strategia industriale (o anche artigianale) per lanciarlo e sostenerlo. Un brand, in sostanza.
E pubblico e marchio sono due elementi imprescindibili dell’identità. Che sia un azienda, un prodotto, una televisione o, infine, un giornale. Che sia un giornale globale, un giornale locale o anche “soltanto” un blog.
(foto via)