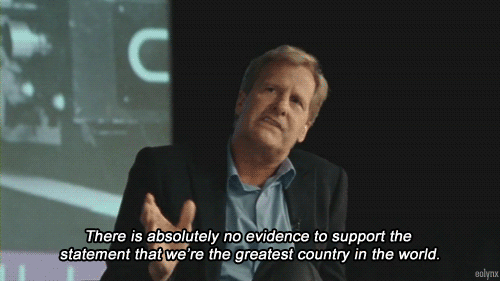Questa settimana in RoundUp: il report della Columbia Journalism School sul giornalismo post-industriale e il futuro dei media; l'esaltazione del giornalista 'brand', sempre più più storyteller e carismatico, e l'esempio di Nate Silver; il caso Rudoren-NYT, che ha costretto la testata ad affidare la giornalista ad una sorta di social media-sitter; e infine uno studio dell'Università del Texas sulla sensazione da information overload.
Giornalismo «post-industriale» e sopravvivenza
Buona parte del dibattito giornalistico in Italia e all'estero di questa settimana si è sviluppato attorno a un rapporto della Columbia Journalism School redatto da C. W. Anderson, Emily Bell e Clay Shirky. Lo studio, dal titolo "Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present" e scaricabile gratuitamente in pdf e in versione ebook, cerca di delineare un quadro sullo stato attuale dell'editoria e sul futuro del giornalismo partendo da alcuni punti chiave categorici: la necessità di trovare una sostenibilità economica e l'incapacità di ristrutturare metodi e prodotti comportata dall'irruzione di Internet - coi relativi vantaggi dati dalle nuove e molteplici opportunità e gli svantaggi derivanti dall’alternativa del digital advertising.
Una rivoluzione che non ha portato soltanto allo smembramento delle redazioni classiche, e che le ha costrette a fare «di più con meno», ma che ha comportato anche la messa in discussione del ruolo del lettore (anzi, per dirla alla Jay Rosen, ciò che un tempo si definiva lettore) come attore non più semplicemente passivo - «È forse tempo di dimenticare l'idea di qualcosa chiamata 'stampa' che gode di una certa reputazione presso un gruppo di persone chiamato 'pubblico'». E ripensare anche la figura del giornalista - non «replaced but displaced» - che dovrà sempre più imparare a farsi da interprete di scenari, fungere da filtro fra informazioni verificate, segnalazioni e news stream derivanti dai social media, e fondare il proprio lavoro su autorevolezza personale, efficenza e persino carisma per stagliarsi, fra gli altri, come attore sempre più credibile nell'intero ecosistema informativo. Il giornalismo, in questo modo, dovrebbe diventare una sorta di «information performance», da preferire alla semplice e ormai sterile «disseminazione di notizie». Che è ciò che contraddistingue i giornalisti - ossia l'intervento umano e professionale - dalle macchine, dagli aggregatori, dai social media, dagli algoritmi: farsene interprete e produrre contenuti originali e adattabili su più piattaforme.
Uno degli aspetti sottolineati dallo studio della Columbia è infatti il vero e proprio lancio del guanto di sfida nei confronti degli operatori giornalistici: riuscire a navigare in acque nuove e sconosciute richiede capacità d'adattamento e freschezza, in uno scenario appunto post-industriale nel quale, qualsiasi modello di riproduzione economica il sistema editoriale sarà in grado di trovare, non sarà comunque capace di fornire gli stessi benefici economici e lo stesso status professionale che il mestiere ha garantito per decenni: non si tratta di trovare un nuovo business model, precisano gli autori, dacché non si intravede ancora un'alternativa credibile, né è possibile scorgere quale possa essere il futuro del panorama editoriale - sia perché il futuro, rammentano, è già qui, sia perché una cosa chiamata news industry in realtà non esiste già da tempo.
Il report è stato analizzato da numerosi autori e lo si può leggere in sintesi grazie al lavoro critico di Joshua Benton su NiemanLab. Considerato un vero e proprio manifesto, da alcuni una pietra miliare della ricerca sui media attuali e sulla futuribilità del mestiere giornalistico, ha incontrato comunque alcune critiche. Fra queste, da segnalare una delle più emblematiche - seppure rispettosa del lavoro dei tre autori - di Mathew Ingram su GigaOM, secondo il quale lo scritto, in tutto il suo interesse, rischia comunque di parlare solo a una platea di «convertiti», che già conoscono lo scenario e lavorano per il cambiamento da tempo. Tuttavia, il senso - e forse anche la morale - che a termine delle 122 pagine gli autori si sentono di dare sta forse nella raccomandazione finale: «Survive».
L'esaltazione del giornalista ‘brand’
Uno degli aspetti più interessanti della ricerca è probabilmente proprio l'attenzione riposta sulla figura del singolo giornalista, inteso come interprete unico - a prescindere dal brand editoriale per il quale lavora - di uno scenario, autore di un quadro con tanto di firma attraverso modi diversi dalla classica produzione giornalistica (e ottenendo risultati e ritorni economici diversi). «I giornalisti non sono più semplicemente dispensatori di notizie»: nello spostamento di questa figura professionale, nella catena di produzione editoriale, dal 'monte' dell'osservazione iniziale dei fatti alla 'valle' della verifica e dell'interpretazione, l'approccio alla notizia e al pubblico del giornalista diventerebbe più simile a quello del traduttore, in un certo senso. Dello «storyteller».
Su questo passaggio del report - e sul tema in generale - pone l'accento Jeff Sonderman su Poynter, in un post dal titolo "Just the facts isn't good enough for journalists anymore". Le news non bastano, dunque: in un’era sempre più caratterizzata dalla sovraesposizione quasi aggressiva alle notizie, della velocità di scrittura e lettura, i lettori potrebbero non accontentarsi di ricontestualizzazioni generaliste apportate da autori ‘medi’. Da qui l'invito a rimodulare la professione: a prevalere, col tempo, dovrebbe essere la personalità dell'autore, la sua «energia», una sorta di valore aggiunto: più ci sentiamo incoraggiati alla partecipazione da autori ai quali siamo in un certo senso fidelizzati – suggerisce - più vogliamo sentire il suo racconto delle cose. E non più semplicemente il suo punto di vista. Certo, avverte ancora la ricerca, la capacità di interazione coi lettori, di far fruttare la propria personalità in termini di audience, di giocare sul filo del carisma, non sono qualità che si possono imparare. Ma non sono più una semplice opzione.
La necessità di puntare sul ‘brand personale’ è tema affrontato in queste ore anche da James Breiner su International Journalists' Network e sul suo blog. Secondo quanto riportato dal suo post, il direttore del New York Times Jill Abramson avrebbe notato, fra i dati sugli accessi al sito della testata, che metà dei contatti ottenuti nel periodo appena precedente all'elezioni americane sarebbe stato ottenuto grazie al solo Nate Silver, l'autore del blog FiveThirtyEight noto per le sue previsioni elettorali dimostratesi poi straordinariamente attendibili. «Ha una grossa, grossissima readership. Non venivano sul sito per il resto del giornale: venivano per lui». In altre parole, quello che molti definiscono sviluppo di un ‘personal brand’, addirittura più forte - in questo caso - di quello dello stesso Times. Ossia, in un certo senso, la dimostrazione plastica di quanto contenuto e consigliato nel report di Anderson, Bell e Shirky, in previsione di uno scenario nel quale il 90% delle news rintracciate in rete sarà assemblate e riproposte da algoritmi, appiattendo così gli standard e dando l'opportunità al giornalista - e alla sua personale platea - di apportare il già citato valore aggiunto (persino il creatore dei due noti aggregatori Techmeme e Mediagazer Gabe Rivera ammette di recente di cominciare a sentire il bisogno di redattori ‘umani’).
Una 'social media-nanny' per il New York Times
Tuttavia, la polarizzazione del lavoro giornalistico - e dei risultati in termini di contatti unici e 'influenza' nei social media - sulla personalità del solo autore rischiano di sovraesporre il giornalista a rischi sempre maggiori, fino a portarlo a danneggiare da solo l’immagine di testate intere come rappresentante involontario, di queste, su piattaforme come Facebook e Twitter - ibride per la loro natura conversazionale e informale e contemporaneamente funzione di ‘presidio’ e estensione del lavoro giornalisitco oltre l'articolo e la redazione. Capita quindi che collaboratori e giornalisti possano esprimersi in maniera impropria sui social network - malgrado la codificazione di norme e best practice redazionali, come abbiamo già visto - e che le testate ammoniscano e prendano provvedimenti a causa di un comportamento giudicato improprio da parte di un proprio collaboratore. Ed è il caso, in questi giorni, della Bureau Chief da Gerusalemme del New York Times Jodi Rudoren.
Prendete un giornalista che ama confrontarsi coi lettori, spontaneo, personale, con uno degli incarichi più delicati nella gerarchia di un giornale, in uno scenario altrettanto delicato - commenta la Public Editor del Times Margaret Sullivan. «Il risultato sarà quasi sicuramente problematico»: la giornalista ha infatti pubblicato su Twitter e Facebook impressioni personali e reputate dai lettori eccessivamente parziali che hanno portato la testata ad affiancare alla Rudoren un social media editor 'personale'. «L'idea è di continuare a mantenere la promessa del coinvolgimento con i lettori sui social network, pur non esponendo il Times ai danni che possono provenire da «pensieri inediti e non filtrati di un giornalista», ha spiegato la Sullivan.
Con tutto ciò che ne consegue: è giusto, come dubitano alcuni, minare la libera espressione di un utente che, benché professionista, è pur sempre essere umano e capace di opinioni personali e incontrollate? O, al contrario, è giusto richiedere standard comportamentali precisi e dignitosi persino nella vita social al di fuori del recinto lavorativo? E ancora: è giusto arrivare a decidere di affiancare dei veri e propri social media-sitter a professionisti dell'informazione? La protagonista della vicenda, intanto, confessa di non sentirsi punita, ma anzi di apprezzare la cosa come gesto «costruttivo»: sono terreni molto sensibili, «proviamo in questo modo, e vediamo come va». Come già prescritto altrove e riassunto in precedenza, cautela e «don't do anything stupid», ma stavolta con un angelo custode.
Information overload? Dipende da dove leggiamo
E d'altro canto, a data piattaforma, corrisponde generalmente un diverso atteggiamento degli utenti, che in termini giornalistici conduce a delle pratiche più o meno codificate, ma che dalla parte dei lettori coincide a diverse modalità di lettura della notizia. Oltre al mercato e alle strutture della produzione giornalistica, sono infatti proprio i metodi di lettura ad essere cambiati e a cambiare l'approccio dei lettori con le notizie, e il comportamento di questi in un ambiente sottoposto a informazioni sempre più numerose, ma non per questo necessariamente capace di informare meglio. La questione è oggetto di un altro studio, stavolta della scuola di giornalismo della University of Texas, analizzato questa settimana da Justin Ellis. La tesi forte del paper solleva infatti più di un dubbio sui processi di assunzione delle news, puntando lo sguardo sul mezzo più che sul contenuto: e se fossero i modi coi quali scegliamo cosa scegliere, su quali strumenti e con quali dispositivi, e non cosa e quanto leggiamo, a condizionare la sensazione - sempre più percepita - da information overload?
La sovraesposizione alle news, secondo lo studio condotto da Avery Holton e Iris Chyi, sarebbe infatti influenzata dal supporto utilizzato per la loro lettura: su 750 adulti osservati nelle loro abitudini informative i casi di eccessiva sovraesposizione alle informazioni si sarebbero verificati maggiormente su mezzi come computer in generale, e-reader e Facebook. Correlazione negativa per quanto riguarda tv e iPhone, e nessuna relazione statistica con supporti come iPad, Twitter e magazine. In sostanza, secondo la ricerca, il medium utilizzato per la lettura sarebbe in grado di condizionare questo tipo di sensazione: sarà quindi più difficile sentirsi «inondati» consultando il proprio smartphone o il proprio tablet, strumenti che in qualche modo - grazie alle app, che isolano la lettura su un unico canale ed enfatizzano leggibilità e contenuti interni al supporto stesso - garantirebbero un'esperienza di lettura meno oppressa e senza distrazioni. All'opposto, sarà più facile sentire il peso dell'overload sui computer, utilizzando browser magari «con quaranta schede aperte», suggerisce Ellis (da leggere anche John Biggs su Techcrunch a proposito del perché si pubblicano sempre più contenuti sui siti di informazione).
E se la relazione fra lettura, strumenti più aperti e media più ‘monodirezionali’ come tv e stampa appare quasi evidente, più interessante e curioso è invece l'esito della ricerca per quanto riguarda i social network. Se è vero infatti che Facebook, sempre stando allo studio, aumenterebbe questo senso di «sopraffazione» da notizie, la stessa cosa non si potrà dire per Twitter - malgrado su entrambe le piattaforme vengano pubblicati, in uno stream senza sosta, link e informazioni di vario genere. La spiegazione data dalla ricerca è che pare plausibile ritenere che gli utenti cambino i loro atteggiamenti al variare della piattaforma utilizzata: saranno quindi più disposti ad affrontare la sovraesposizione da news su uno strumento più focalizzato sull'aggiornamento in tempo reale e costante come Twitter, è invece possibile che la sensazione da information overload aumenti sulle bacheche di Facebook, dove «non hai altra intenzione se non quella di vedere cosa fanno i tuoi amici».
Ultima immagine via NYT.