La rete, oltre alla sfida di un nuovo giornalismo, ha imposto anche la sua riorganizzazione produttiva e il cambiamento radicale del rapporto fra prodotto, prestazione e ricavi economici. Questa settimana si parla del paradosso della sovrapproduzione dei contenuti a fronte del crollo delle entrate pubblicitarie, del caso del tweet di Oreo durante il Super Bowl, dei pro e contro dell’editoria online e della distanza, sempre crescente, fra giovani e giornali.
Il paradosso della produzione in rete: più contenuti meno pubblicità
Uno degli articoli più discussi degli ultimi giorni è stato «Another blog post that won't make any money» di Ryan McCarthy su MediaFile. Nel pezzo l'autore mette in risalto i paradossi della produzione mediatica online: un mercato dove l'eccesso di offerta non giustifica sforzi e entrate, nel quale ogni giorno si produce sempre più giornalismo, e in modi sempre diversi, senza particolari benefici economici - analisi, grafici, foto, tweet e conversazioni coi lettori, slideshow, video, GIF animate, per un pubblico più vasto distribuito su varie piattaforme e al quale si offrono, declinandoli, contenuti prima impensabili. Qualcosa che generalmente dà l'opportunità agli inserzionisti di occupare ancora più spazi e ottenere maggiore visibilità. Ma che malgrado ciò non impedisce alle entrate pubblicitarie di crollare da anni.
Per spiegarlo, McCarthy cita Frederic Filloux, General Manager del digital a Les Echos: è «economicamente assurdo: in un mondo 'normale', quando il pubblico cresce, la pubblicità raggiunge più utenti e, come risultato, il prezzo di questa sale». Ma così non appare: si sta cercando in diversi modi - nota il post - di trovare una soluzione al dilemma, a cominciare dai noti - e spesso controversi - esperimenti di native advertising, o ancora puntando sui contenuti e sui propri lettori, come al New York Times, dove i dati degli ultimi giorni confermano il distacco fra le entrate derivanti dagli abbonamenti e le ad revenue. Comunque, una questione che l’incontro tra curve di domanda e offerta sembra quasi non riuscire a spiegare: «La parte di tempo che trascorriamo in rete è cresciuta fino al 40% negli ultimi tre anni. Mentre la pubblicità - continua - diventa sempre meno costosa».
Touchdown per Oreo
L'esempio lampante di un possibile modo nuovo e quasi del tutto gratuito di fare pubblicità online proviene proprio dalle cronache dell'ultima settimana. Durante il terzo quarto del Super Bowl, la finale di football tra Baltimora e San Francisco, un black-out dell’impianto elettrico ha costretto lo stadio al buio per 34 minuti. L'episodio è diventato uno spunto per il social media team di Oreo, una nota marca di biscotti, che ha quindi twittato dall'account del brand «Power Out? No problem: puoi inzuppare anche al buio», con biscotto che si staglia nell'oscurità: la foto, in sostanza un banner pubblicitario adattato alla strettissima attualità, è stata ritwittata da più di 16 mila utenti e 'apprezzata' da 20 mila su Facebook - che proprio non saranno numeri da esibizione di Beyoncé, fa notare Angela Watercutter su Wired, ma comunque un risultato niente male «per un biscotto». La società che si è occupata della gestione dei social di Oreo per l'evento parla di combinazione di velocità e adattamento alle sensazioni: «You need a brave brand to approve content that quickly. When all of the stakeholders come together so quickly, you've got magic». Una situazione quasi irripetibile - riportata da BuzzFeed - per capitalizzare al meglio un evento inaspettato.
La questione del paradosso iniziale resta viva: «In un ambiente - continua Watercutter - nel quale si spendono 4 milioni di dollari per uno spot durante la finale (e Oreo ne ha presentato comunque uno, peraltro tra i più apprezzati, nda), avere un brand che risponde in tempo reale sui social media è una mossa intelligente per raggiungere persone su smartphone e computer». Soprattutto se si considera un dato preciso: quel 36% di spettatori che ha assistito al Super Bowl «consulting a second screen», e in special modo su Twitter (cosa della quale si sono accorti anche gli inserzionisti). Un semplice box, a fronte di produzioni costose per un mezzo più vecchio ma ancora influente come la televisione. Secondo alcuni, un episodio da relegare al dibattito specialistico del digital marketing, dando all’argomento l’adeguata rilevanza ‘settoriale’. Ma certamente, per i media in generale, un case history del quale tenere conto, specie se lo si guarda nella prospettiva della velocità di produzione e condivisione su più piattaforme.
Pro e contro dell'editoria online
Si produce di più, più velocemente e con più mezzi, finendo col degradare il lavoro professionale: è la ruota del criceto, la «hamsterization» citata questa settimana da Jay Rosen, in un altro dei pezzi più discussi degli ultimi giorni. Nel post - dall'eloquente titolo «Look, you're right, okay? But you're also wrong» - Rosen analizza prima le cause della progressiva distruzione del lavoro di redazione tradizionale, dovuta all'imporsi delle nuove logiche editoriali di internet applicate alla professione. La corsa al click facile «stupida e non etica», il pericolo della riproduzione amatoriale del mestiere («Bloggers and citizen journalists cannot fill the gap»), praticata da cittadini privi di fonti e strumenti e incapaci di fungere - diversamente dai classici reporter - da «memoria istituzionale della comunità», da 'guardiano' sul posto. Senza dimenticare la questione economica, la ben nota impossibilità di tornare all'industria mediatica di un tempo, dal momento che «l'online advertising non riuscirà mai a sostituire ciò che si è perso», appunto.
Dall'altra parte - o ‘allo stesso tempo’, in questo post-accusa sulle varie credenze riguardo l'industria dei media online - è necessario prendere in seria considerazione gli aspetti positivi di questa rivoluzione, sapendo lavorare su un terreno ormai diverso da quello sul quale si è operato per decenni. Riscrivere definitivamente i metodi di produzione: e dunque saper vedere in Google una risorsa e non una minaccia, ripensare i contenuti per le nuove piattaforme - incapacità particolarmente dannosa, a dispetto del mitologico 'peccato originale' della distribuzione gratuita dei primi contenuti giornalistici in rete. O ancora interagire con il resto dell'offerta («Do what you do best and link to the rest non è uno slogan, è la tua sola speranza per una copertura completa») e coi propri lettori, avendo piena contezza della «business side» della redazione, una mancanza storica - quella del leggere oltre la distinzione «stato-chiesa» fra industria e professione - che secondo Rosen avrebbe portato a veri e propri disastri. «A journalist is just a heightened case of an informed citizen, not a special class. The First Amendment doesn’t mention your occupation; it refers to everyone’s right to publish».
Perché i giovani non leggono i giornali
Intanto i giornali continuano a suscitare sempre meno interesse tra i giovani. Alan D. Mutter questa settimana su Editor & Publisher cerca di spiegarne le ragioni, prendendo spunto da alcuni dati del Pew Research Center: la readership giovanile, negli Stati Uniti, si muove ormai tra il 16% dei quarantenni e il 6% dei ventenni. Un dato certamente da associare al crollo generale dei lettori, che dal '91 al 2012 sono passati dal 56% al 29% della popolazione, ma che non trova attenuanti a uno sguardo più specifico: secondo la ricerca, tre lettori su quattro avrebbero più di 45 anni, sebbene la stessa classe d'età rappresenti solo il 40% dell'intera popolazione, portando a pensare a una sorta di progressiva estinzione del lettore di giornale. Ma per quale motivo?
Abitudine: le generazioni X e Millennial, secondo il post, sarebbero 'cresciute' davanti a uno schermo, televisore o tablet che sia, e dunque poco avvezze ad altre metodologie di consumo - spiegazione che non riuscirebbe tuttavia a giustificare alcuni recenti dati sulle versioni digitali proposte dal 65% dei magazine americani, che rappresentebbero meno del tre percento della diffusione totale. Sono i cosiddetti 'nativi digitali', che preferirebbero, secondo una vecchia ricerca del Washington Post citata dall'autore, flessibilità e convenienza - quindi puro web environment - ai costi e all’acquisto effettivo, alla proprietà 'fisica' . Una generazione che secondo Mary Meeker sarà destinata a cambiare ogni cosa, ogni processo, dai semplici consumi all’esercizio di diritti quali educazione e salute. Il New York Times, nel frattempo, starebbe pensando a una sorta di giornale entry level per iniziare i lettori più giovani a un prodotto della testata. Laura Hazard Owen, su Paid Content, prova a immaginare come potrebbe essere: life style e firme alla Krugman (sullo stile del ‘giornalista-brand’ di cui abbiamo già parlato), altamente personalizzabile, sui 10-15 dollari al mese.


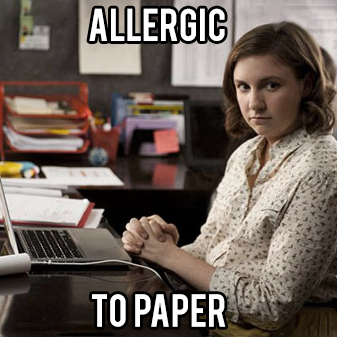



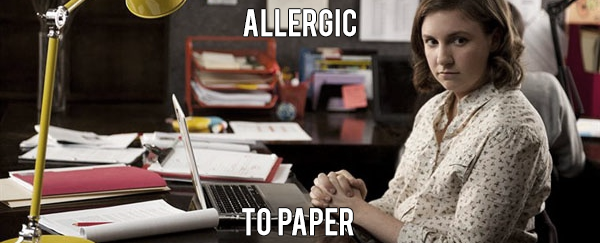
…voglio i contatti del vostro spacciatore di gif animate xD
[…] della rinascita del Naples Daily che ha sfruttato dimensioni (ridotte) e età media (60 anni, sempre più target di riferimento per i quotidiani) dell’area urbana in cui viene distribuito, crescendo in termini di ricavi fino al 10% dal […]