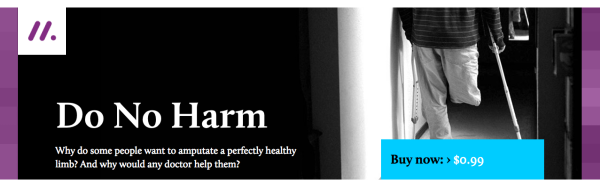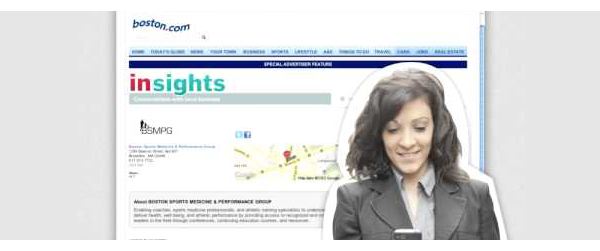Quello della sostenibilità giornalistica è uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni nel settore dei media. E i modelli sperimentati, in tal senso, si fanno sempre più numerosi - da un lato grazie ai nuovi strumenti digitali, estremamente diffusi e alla portata di tutti, dall'altro per ovviare il prima possibile a una crisi di settore che si è poi scontrata, fatalmente, con quella pubblicitaria e più in generale con quella economica. Questa settimana ha preso il via un progetto che cerca di lanciare lo sguardo su più fronti, Matter, e si è consolidata la pratica pubblicitaria del native advertising. Intanto un formato nuovo (ma vecchio di 25 anni) come quello delle immagini GIF è stato eletto - sotto forma di verbo - a parola dell’anno, e una ricerca, negli Usa, ci ricorda che non sono pochi quelli che ritwittano articoli senza leggerli (i cosiddetti blind retweet).
La sfida di Matter a qualità e sostenibilità economica
Mercoledì 14 novembre Bobbie Johnson di GigaOM e il freelance Jim Gales hanno pubblicato il primo articolo di Matter, la loro creatura giornalistica multicanale nata grazie al sostegno dei contributi raccolti su Kickstarter attraverso il modello del crowdfunding: cinquantamila dollari l'obiettivo, 140 mila dollari il risultato finale, un enorme successo che li ha spronati a continuare e a ripagare tanta fiducia. Ma non è soltanto il finanziamento dal basso l'unico aspetto peculiare del caso: Matter venderà i propri articoli su Kindle Store e iTunes in formato MOBI e EPUB, nonché ovviamente sul sito: 99 centesimi per l'accesso completo ai contenuti online, alle versioni in audiobook, la possibilità di prendere parte al dibattito post-pubblicazione con gli autori e aderire a una sorta di membership con lettori e collaboratori. Un ulteriore aspetto degno di nota, infine, riguarda i contenuti: si tratterà di brani di longform journalism da minimo 5000 parole e di carattere scientifico-tecnologico. Una sfida, quindi, per formato, canale, finanziamento e tematiche.
Il primo pezzo, uscito appunto in settimana, è un reportage di circa 7700 parole redatto dall'autore scientifico Anil Ananthaswamy dal titolo «Do No Harm», sulle amputazioni, i disturbi da Body Integrity Identity Disorder e il lavoro dei chirurghi che rischiano la vita per aiutare chi ne è affetto. Gli inventori del progetto, intanto, si dicono soddisfatti: sono entusiasti dalla possibilità di mostrare al loro pubblico il lavoro che avevano immaginato, e vanno fieri della scelta e del risultato finale del primo articolo, sul quale chi ha lavorato lo ha fatto duramente per portare a casa «un tipo di racconto che difficilmente si trova da altre parti». Fiducia quanto alla sostenibilità del progetto: «Le persone erano molto felici di pagare per informazione di qualità», e d'altro canto il forte supporto arrivato dal finanziamento dal basso fa pensare a una comunità di base piuttosto larga e motivata, che avrà peraltro l'occasione, a abbonamento sottoscritto, di suggerire tematiche e storie, e commentare e rifinire quelle altrui, sulla piattaforma opensource All Our Ideas.
Ma sarà davvero applicabile il modello iTunes al giornalismo? E più in generale, riuscirà Matter a sopravvivere? Felix Salmon di Reuters crede che il progetto, in questo senso, abbia delle buone possibilità: «Penso che il successo della campagna su Kickstarter sia la prova del fatto che c'è un'enorme e inevasa domanda per questo tipo di prodotto - domanda che non trova risposta in concorrenti come Scientific American o Popular Mechanics». Più pessimista, invece, la Science Reporter del New York Times Natalie Angier, interrogata da Mallary Jean Tenore su Poynter: «La gente pagherà per leggere lunghi, bellissimi e provocatori articoli scientifici? E Matter pagherà ai propri collaboratori un salario minimo in grado di venire incontro a questo desiderio? Sono scettica». Quanto ai pagamenti, comunque, è Johnson stesso a chiarirne i termini su PaidContent: «Paghiamo gli autori con tutti i mezzi che possiamo. Al momento, ci basiamo principalmente sul modello flat fee, ossia in base alla lunghezza del testo. Ma quando avremo dati concreti sulle vendite sperimenteremo con la divisione di quote e altre opzioni».
«Il native advertising ci salverà. Forse»
Altra notizia della settimana dal fronte del futuro del giornalismo - o meglio, della sua sostenibilità economica - arriva dagli Stati Uniti: Boston.com, versione online della testata The Boston Globe, ha infatti deciso di «abbracciare la tendenza» del native advertising, buzzword di recente sulla bocca di molti nel settore, che identifica quel tipo di inserzione pubblicitaria online che viene impaginata e proposta come un normale articolo, ma segnalata come «special advertiser feature». Gli inserzionisti saranno infatti liberi di pubblicare autonomamente i loro articoli-inserzione all'interno di un programma denominato Insight e da lì pubblicizzare i prodotti o i servizi offerti. I post appariranno poi in diverse sezioni del sito in un box, in modo da raggiungere e informare il potenziale cliente in maniera diversa dal classico sistema 'a banner', ormai genericamente reputato fastidioso fino all'essere quasi schermato e sorpassato dai diversi plug-in che ne permettono il facile oscuramento messi a disposizione dai browser.
Ma perché scegliere questa strada? Principalmente, perché si sta cercando un nuovo modo di incontrare l'interesse dei lettori-utenti attraverso nuovi strumenti, il più possibile diversi dai display ad, diventati ormai quasi ininfluenti e cliccati - secondo Forbes - solo otto volte su diecimila. Troppo poco per basare la propria sopravvivenza su questo tipo di strumento. Necessario sarebbe quindi – secondo il Chief Product Officer di Forbes Lewis Dvorkin - catturare realmente l'attenzione del lettore, e non limitarsi all'impressione sullo schermo, giacché adesso gli inserzionisti preferiscono di gran lunga «che i loro contenuti vengano letti, discussi, condivisi - proprio come gli articoli dei giornalisti». O come i lettori: la chiave starebbe proprio nella discussione e nella condivisione, nella comunicazione social tra brand e consumatori, due attori che «utilizzano adesso gli stessi strumenti e appaiono negli stessi content stream» - continua Dvorkin. Superare, più semplicemente, la differenza fra «i brand come venditori noiosi, che cercano di attrarre l'attenzione degli utenti verso cose di cui a loro non importa, e content-creating friend, che suggeriscono, raccomandano, chattano con loro» - precisa Erin Griffith su PandoDaily. Cogliere l’utente nel momento in cui è più disposto a leggere e informarsi, se gli si propone un contenuto - benché pubblicitario - sotto forma di articolo. «Native ads are digital ads that don’t suck. That may be because they weren’t invented by advertising people», precisa molto chiaramente, in un post dal titolo «Il native advertising ci salverà tutti. Forse».
Il Boston Globe però è solo l'ultima delle testate giunta sul terreno, come segnalato su Emediavitals: tool simili per inserzionisti sono previste da tempo anche su Forbes - col nome di BrandVoice, su The Atlantic attraverso i microsite, e la sua costola finanziaria Quartz - come già visto qualche settimana fa - per mezzo dei Quartz Bulletin. E da BuzzFeed, che integra i suoi featured partner content nello stream editoriale, e che durante l'ultima campagna elettorale per le presidenziali ha addirittura concesso dei post allo staff di Barack Obama sotto la dicitura paid political advertising. Non sono poche, tuttavia, le testate scettiche. Forti anche dei dati: secondo uno studio pubblicato in settimana da MediaBrix, la gran parte degli adulti online raggiunti dalla ricerca giudica questo tipo di inserzioni «misleading», fuorvianti, ingannevoli (il 66% per gli articoli, l'86% per i video che non sembrano promozionali). Ben più dei promoted tweet (ritenuti fuorvianti dal 45% degli intervistati) e delle Facebook sponsored story (57%). «È estremamente importante per noi che appaia netta la distinzione fra editoriali e news per i lettori. A maggior ragione, non siamo inclini a questo tipo di pubblicità» ha spiegato per esempio Eileen Murphy del New York Times. Ma nel frattempo, su PaidContent.org, Jeff John Roberts si chiede se la 'grigia signora' potrà permettersi ancora per molto il lusso di ignorare questa alternativa.
‘To gif’ parola dell'anno
Ma sono stati i giorni, questi, anche dell'incoronazione ufficiale del termine GIF a parola dell'anno: si tratta di quel formato digitale per le immagini (acronimo di graphic interchange format) creato 25 anni fa che viene utilizzato per riprodurre animazioni in loop di pochi secondi, inquadrare frame di un video, animare foto di carattere artistico, dare movimento ai meme, proprio per la sua caratteristica tecnica principale: la possibilità di inserire una o più immagini nello stesso file, poi riprodotte una dopo l'altra. E così martedì è stata proprio la Oxford American Dictionary a dichiarare il verbo to gif, ossia «creare un file GIF (immagine o video sequenza, specialmente collegata a un evento)» a termine del 2012, una pratica che, persa la propria spinta dopo gli anni novanta - anni nei quali rappresentava uno degli strumenti irrinunciabili per la decorazione dei primi siti internet - col mutare dell'estetica in rete ha conosciuto una nuova 'primavera' su piattaforme come Tumblr (che non a caso proprio in questi anni è cresciuta esponenzialmente, raggiungendo un aumento nelle pageview del 1540 percento da ottobre 2009 a ottobre 2010). Uno strumento certamente divertente, del quale si comincia a discutere anche dal punto di vista della produzione giornalistica online (qui una guida di Poynter per giornalisti che intendano saperne di più e cominciare a dominare lo strumento), imponendosi come argomento di dibattito a seguito dell'uso che delle GIF è stato fatto durante le Olimpiadi, la campagna per le presidenziali americane, eventi come l'arrivo dell'uragano Sandy e su siti di informazione come Gawker e BuzzFeed.
Utilizzate anche nel mercato musicale e nella moda - dove riescono in qualche modo a ovviare all'appiattimento su due dimensioni degli shooting fotografici - e dopo aver convinto persino Amazon a «entrare nello spirito», le GIF, perfette nella riproduzione veloce e simbolica degli eventi con un effetto storytelling immediato, si avviano a conquistare per qualche tempo l'egemonia delle immagini in rete, un luogo dove - come abbiamo visto la scorsa settimana - sono proprio le foto e i simboli istantanei a prevalere nella consultazione veloce e non troppo ragionata dei contenuti, specie da dispositivi mobile. Tuttavia, fa notare Ritchie King su Quartz, come formato digitale per immagini non è mai stato meno popolare quanto oggi. «Secondo Internet Archive - spiega - le GIF ora comprendono il 29% delle immagini del milione di siti più popolari del web, in discesa rispetto al 41% di due anni fa. E a questa velocità potrebbero sparire completamente dalla rete alla fine del decennio». Spiegarlo è semplice, continua King: non si tratta di un ottimo formato, quanto a prestazioni, colori poco nitidi, e dimensioni del file. Uno strumento che ad oggi dimostrerebbe tutti e venticinque i suoi anni di 'servizio', e che tecnicamente non può essere in grado di competere con i più 'performanti' PNG - che si avvia a dominare il prossimo futuro nel settore - e JPEG. Ma finché ci sarà domanda di gattini animati, conclude l'articolo, le GIF non moriranno mai.
D'altra natura invece è la critica che arriva da Slate. Secondo Kay Waldman in realtà non sarebbe poi così tanto usuale veder usare la parola gif come verbo. Cosa che non ne giustificherebbe la nomina da parte dell'Oxford Dictionary a parola dell’anno, a dispetto delle più quotate Obamacare, Eurogeddon, Superstorm, Higgs Boson e Nomophobia (qui invece, secondo Le Nouvelle Observateur, i cinque motivi per festeggiare la scelta). E poco importa se sono state 'ufficialmente' adottate anche da testate della portata di New York Times e New Yorker. Quanto meno, chiosa Waldman, «questi termini interwebby», eletti di recente a parole simbolo come to tweet e to google, «col tempo hanno provato la loro longevità. E almeno adesso sappiamo come pronunciarli».
I 'blind retweet'
Una delle metriche più quotate per stabilire se un contenuto o una testata 'funziona' in rete è il grado di discussione e condivisione che questi producono - che su Twitter si esprimono, com'è noto, soprattutto attraverso i retweet. Ma è sempre vero che alla condivisione di un articolo corrisponda necessariamente la lettura? È necessario aspettarsi che ad ogni RT sia legato l'approfondimento del contenuto condiviso? È la tesi esposta da Kevin Loker su Mediabistro, che prende le mosse da una ricerca compiuta dal Social Media Scientist di Hubspot Dan Zarrella sui flussi e i click generati dalle condivisioni su Twitter. Zarrella ha analizzato 2,7 milioni di tweet con link, scoprendo infatti che il 16,2% di questi hanno generato più retweet che click per il sito linkato, e che il 14,64% dei link ritwittati non è neanche mai stato visitato. Ossia scoprendo, in sostanza, che sono molte le persone che ripubblicano contenuti senza neppure aprire la pagina collegata: ciò che nel post viene definito un retweet 'cieco'.
«Forget about 'RT are not endorsement'» - spiega Loker: «RTs may not even be an acknowledgement that a particular link was clicked, let alone read». Ma com'è possibile? Il fenomeno potrebbe trovare spiegazioni nell'assunzione rapida di particelle di notizie oggi raggiungibili ovunque, di piccolissimo formato e immediata condivisione, facendo delle frasi di lancio delle news una sorta di slogan da appoggiare - appunto - ciecamente, senza la piena presa di coscienza derivante dalla lettura. Ma una caratteristica che comunque, nota l'autore, non può essere esclusivamente addebitata all'utilizzo dei nuovi media: «Ai tempi dei giornali era facile trovare chi non leggeva articoli per intero, limitandosi a short bit simili, i titoli. Un tweet è una nuova forma di titolo, e certamente oggi abbiamo chi legge quei 140 caratteri o poco meno e poi va avanti». Con la differenza, però, che su Twitter è l'utente stesso a ripubblicare la micro-informazione, a farsene portavoce coi propri follower, a crescere come «thought leader» e quindi, in qualche modo, a portare la responsabilità di una condivisione 'indiscriminata'.
In rete, e anche sullo stesso Mediabistro, non mancano le guide all'ottenimento del retweet facile. E certamente la condivisione 'cieca' non impedisce ai follower raggiunti di ritrovare e leggere l'articolo linkato - «Che va bene, ma non è l'ideale», continua l'articolo. Eppure un dato del genere di sicuro rischia di minare alla base uno dei miti più recenti della pubblicazione e condivisione dei contenuti online: quell'engagement - ossia il coinvolgimento attivo dell'utente-lettore - che sempre più spesso viene segnalato come indicatore del successo dei prodotti editoriali in rete. E che probabilmente, da solo, non riuscirà a salvare il giornalismo: «L'engagement sui social media come brand o persona va bene, sicuramente, e su più livelli. Ma se si tratta di retweet di link a articoli che i ritwittatori non hanno mai letto, in che modo può essere utile? Un retweet cieco può servire per spingere il tuo brand - sintetizza Mediabistro - ma rischia di non esserlo per ciò che è il primo obiettivo del giornalismo: informare il pubblico».